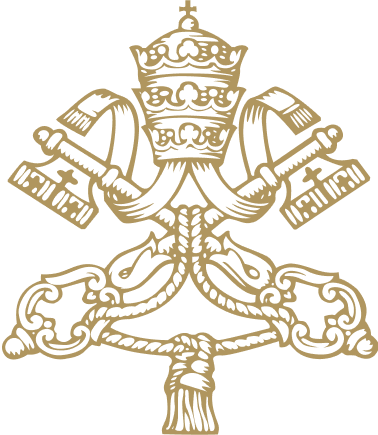DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE "REGINA COELI" DI ROMA
Aula Paolo VI
Giovedì, 7 febbraio 2019
Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di incontrarvi e vi saluto tutti cordialmente, ad iniziare dal Cappellano padre Vittorio Trani e dal Direttore dr.ssa Silvana Sergi, che ringrazio per le loro parole. Voi rappresentate la comunità di lavoro che si pone al servizio dei detenuti del carcere romano di “Regina Coeli”: agenti di custodia, personale amministrativo, medici, educatori, cappellani e volontari, accompagnati dai vostri familiari. Esprimo a ciascuno la riconoscenza mia e della Chiesa per il vostro lavoro accanto ai reclusi: esso richiede fortezza interiore, perseveranza e consapevolezza della specifica missione alla quale siete chiamati. È un’altra cosa. Ci vuole preghiera tutti i giorni perché il Signore vi dia il buon senso: il buon senso nelle diverse situazioni nelle quali vi troverete.
Il carcere è luogo di pena nel duplice senso di punizione e di sofferenza, e ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, Polizia Penitenziaria, Cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di curare le ferite di coloro che, per errori fatti, si trovano privati della loro libertà personale. È noto che una buona collaborazione tra i diversi servizi nel carcere svolge un’azione di grande sostegno per la rieducazione dei detenuti. Tuttavia, a causa della carenza di personale e del cronico sovraffollamento, il faticoso e delicato lavoro rischia di essere in parte vanificato.
Lo stress lavorativo determinato dai turni pressanti e spesso la lontananza dalle famiglie sono fattori che appesantiscono un lavoro che già di per sé comporta una certa fatica psicologica. Pertanto, figure professionali come le vostre necessitano di equilibrio personale e di valide motivazioni costantemente rinnovate; infatti siete chiamati non solo a garantire la custodia, l’ordine e la sicurezza dell’istituto, ma anche molto spesso a fasciare le ferite di uomini e donne che incontrate quotidianamente nei loro reparti.
Nessuno può condannare l’altro per gli errori che ha commesso, né tantomeno infliggere sofferenze offendendo la dignità umana. Le carceri hanno bisogno di essere sempre più umanizzate, ed è doloroso invece sentire che tante volte sono considerate come luoghi di violenza e di illegalità, dove imperversano le cattiverie umane. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che molti detenuti sono povera gente, non hanno riferimenti, non hanno sicurezze, non hanno famiglia, non hanno mezzi per difendere i propri diritti, sono emarginati e abbandonati al loro destino. Per la società i detenuti sono individui scomodi, sono uno scarto, un peso. E’ doloroso questo, ma l’inconscio collettivo ci porta lì.
Ma l’esperienza dimostra che il carcere, con l’aiuto degli operatori penitenziari, può diventare veramente un luogo di riscatto, di risurrezione e di cambiamento di vita; e tutto ciò è possibile attraverso percorsi di fede, di lavoro e di formazione professionale, ma soprattutto di vicinanza spirituale e di compassione, sull’esempio del buon Samaritano, che si è chinato a curare il fratello ferito. Questo atteggiamento di prossimità, che trova la sua radice nell’amore di Cristo, può favorire in molti detenuti la fiducia, la consapevolezza e la certezza di essere amati.
Inoltre, la pena, ogni pena, non può essere chiusa, deve avere sempre “la finestra aperta” per la speranza, da parte sia del carcere sia di ogni persona. Ognuno deve avere sempre la speranza del reinserimento parziale. Pensiamo agli ergastolani, anche loro: “Col mio lavoro in carcere…”. Dare, fare lavori… Sempre la speranza del reinserimento. Una pena senza speranza non serve, non aiuta, provoca nel cuore sentimenti di rancore, tante volte di vendetta, e la persona esce peggio di come è entrata. No. Bisogna sempre far sì che ci sia la speranza e aiutare a vedere sempre al di là della finestra, sperando nel reinserimento. So che voi lavorate tanto, guardando questo futuro per reinserire ognuno di coloro che sono in carcere.
Vi incoraggio a svolgere la vostra importante opera con sentimenti di concordia e di unità. Tutti insieme, Direzione, Polizia Penitenziaria, Cappellani, area educativa, volontariato e comunità esterna siete chiamati a marciare in un’unica direzione, per aiutare a rialzarsi e a crescere nella speranza quanti sono, purtroppo, caduti nella trappola del male.
Da parte mia, vi accompagno con il mio affetto, che è sincero. Io ho tanta vicinanza con i carcerati e le persone che lavorano nelle carceri. Il mio affetto e la mia preghiera, perché possiate contribuire, con il vostro lavoro, a far sì che il carcere, luogo di pena e di sofferenza, sia anche laboratorio di umanità e di speranza. Nell’altra diocesi [Buenos Aires] andavo spesso al carcere; e adesso ogni quindici giorni, la domenica, faccio una telefonata a un gruppo di carcerati in un carcere che visitavo con frequenza. Sono vicino. E sempre ho avuto una sensazione quando entravo nel carcere: “perché loro e non io?”. Questo pensiero mi ha fatto tanto bene. Perché loro e non io? Avrei potuto essere lì, e invece no, il Signore mi ha dato una grazia che i miei peccati e le mie mancanze siano state perdonate e non viste, non so. Ma quella domanda aiuta tanto: perché loro e non io?
Benedico di cuore tutti voi e i vostri cari; e vi chiedo per favore di pregare per me, che ne ho bisogno. Grazie!
Copyright © Dicastero per la Comunicazione