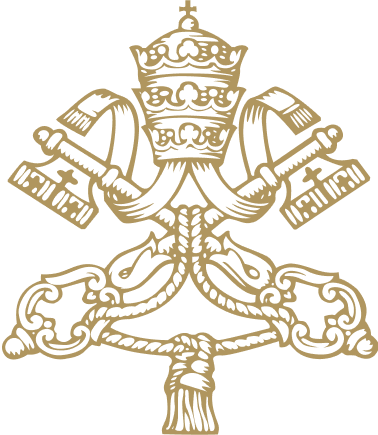DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI MEMBRI DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA,
AI PADRI PENITENZIERI E AI PARTECIPANTI
AL CORSO SUL «FORO INTERO»
Sabato, 18 marzo 1995
1. Riesce sempre caro al mio cuore l’incontro con i fedeli di ogni condizione sociale e canonica, in questa preziosa e pur familiare dimora del Vaticano, accanto al “trofeo” del Pescatore di Galilea, qui ove oggi egli è glorificato, ma un giorno subì il martirio, unito, anche nella forma di esso, al sacrificio salvifico del Redentore. L’universale paternità di Pietro e dei suoi successori è infatti per eccellenza radicata nella croce e, in virtù della croce, è feconda di vita eterna.
Ma questa mia gioia ha una particolare intensità, quando i figli che vengono “videre Petrum” sono i sacerdoti e i candidati al sacerdozio: essi infatti, per la missione di cui sono o saranno presto investiti, sono partecipi delle ansie, delle gioie, dei dolori, della dedizione della Chiesa Madre, la quale, applicando l’efficacia redentrice della croce, opera nei fedeli, anzi, in tutto il genere umano, il dono divino della conversione e della santità.
Rendo perciò grazie al Signore per l’odierno incontro con voi, componenti della Penitenzieria Apostolica, Penitenzieri delle Basiliche Patriarcali di Roma, e cari giovani, novelli sacerdoti o alunni prossimi alla sacra Ordinazione, che avete fruttuosamente preso parte presso la stessa Penitenzieria al consueto corso di studio sul foro interno.
Desidero cogliere questa opportunità per continuare una meditazione, scandita nelle analoghe allocuzioni degli anni scorsi, svolgendo in ulteriori aspetti l’inesausto tema del sacramento della Riconciliazione.
2. Il sacerdote, come ministro del sacramento della Penitenza, deve modellarsi, in questo sublime e vitale compito, su Gesù, maestro di verità, medico delle anime, delicato amico, che non tanto rimprovera, quanto corregge e incoraggia, giustissimo e nobilissimo giudice, che penetra nel vivo della coscienza e ne custodisce il segreto. A Gesù assimilato, il sacerdote confessore deve poter concludere il suo colloquio con il penitente con un fondato auspicio riecheggiante l’infinita misericordia del Signore: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8, 11).
In vista appunto di questa stabile emenda del penitente il confessore, da una parte deve offrirgli motivi di ragionevole e soprannaturale fiducia, che rendano atta la sua anima a recepire fruttuosamente l’assoluzione e garantiscano la continuazione dei buoni propositi in una vita serenamente cristiana, dall’altra deve assegnargli una congrua soddisfazione, o penitenza, che in primo luogo ripari, nella misura possibile alla limitatezza umana, l’offesa recata dal peccato alla maestà di Dio, Creatore, Signore e Legislatore; quindi, come farmaco spirituale, rafforzi, unitamente alla accennata fiducia, i buoni propositi di virtù e, anzi, faccia esercitare le virtù, cooperando con la grazia santificante, restituita o aumentata nel sacramento della Penitenza, che offre anche valida difesa contro le tentazioni più dure.
Per quanto concerne la fiducia da infondere nel penitente in rapporto al suo futuro, si consideri che nel processo della giustificazione, esposto dal Concilio di Trento con mirabile chiarezza, devono concorrere sia il timore che la speranza: “... peccatores se esse intelligentes, a divinae iustitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spe eriguntur, fidentes, Deum sibi propter Christum propitium fore” (Conc. Tridentino, Sess. VI, cap. 6 Denzinger-Schönmetzer 1526).
3. Per eccesso di fiducia, se così si può dire, v’è chi non ricava positiva e stabile emenda, pur confessandosi con verità ed esattezza, perché il non superato orgoglio lo porta a confidare troppo in se stesso, o, ben peggio, a confidare in se stesso anziché nella grazia di Dio. Fenomeno inverso, ma ugualmente grave, è quello di chi fa sì il debito spazio alla grazia di Dio, ma presume alla leggera di ottenerla senza la corrispondenza e la collaborazione, che Dio richiede da parte dell’uomo.
Al contrario, per difetto di fiducia v’è chi o addirittura non si accosta al sacramento della Penitenza, o accostandosi non si pone nelle disposizioni necessarie affinché il rito possa concludersi efficacemente con l’assoluzione, perché, edotto dal suo passato circa la propria debolezza, si ritiene certo di future cadute e, identificando erroneamente il giudizio intellettuale, diciamo pure la previsione di altre cadute, con la volontà di cadere e con l’attuale difetto di sincero proposito di non cadere, si perde d’animo e così dichiara al confessore di non essere debitamente disposto. Sarebbe veramente triste se in tale errore, indice anche di poca conoscenza dell’animo umano, cadesse persino qualche confessore.
A queste disposizioni estreme il confessore deve opporre appropriato antidoto: a coloro che presumono inculchi l’umiltà, che è verità, secondo il monito della divina parola “chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere” (1 Cor 10, 12) e “attendete alla vostra salvezza con timore e tremore” (Fil 2, 12). A coloro che sono paralizzati da quella sfiducia, che non è il debito salutare timore, ma una raggelante paura, spieghi che la consapevolezza della propria infermità non vuol dire quiescenza alla medesima, ma anzi può e deve essere spinta a reagire, perché, anche questa è parola di Dio: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor 12, 9). In merito non sarà fuori luogo ricordare che la fede insegna la possibilità di evitare il peccato con l’aiuto della grazia (cf. Concilio di Trento, Sessione VI, can. 18 Denzinger-Schönmetzer 1568).
4. Quanto alla salutare penitenza da assegnare, criterio necessario è quello di una equa misura e, soprattutto, di una saggia opposizione ai peccati rimessi e quindi di corrispondenza agli specifici bisogni del penitente.
Ascoltiamo anche qui il richiamo della Sacra Scrittura: “Non esser troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato” (Sir 5, 5), e, per quanto attiene alla stessa struttura del sacramento, di cui la penitenza è parte integrante, sentiamo il Concilio Tridentino: “Si quis negaverit, ad integram et perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in paenitente quasi materiam sacramenti paenitentiae, videlicet contritionem, confessionem et satisfactionem, quae tres paenitentiae partes dicuntur; aut dixerit duas tantum esse paenitentiae partes, terrores scilicet incussos conscintiae agnito peccato, et fidem conceptam ex Evangelio vel absolutionem, qua credit quis sibi per Christum remissa peccata: anathema sit” (Denzinger-Schönmetzer 1704).
Sulla scorta di questi insegnamenti e considerando da una parte l’economia della grazia, che accompagna, sostiene ed eleva l’operare dell’uomo, e dall’altra le leggi della psicologia umana, risulta evidente che la soddisfazione sacramentale deve essere innanzitutto preghiera: essa infatti loda Dio e detesta il peccato come offesa a Lui irrogata, confessa la malizia e la debolezza del peccatore, chiede umilmente e fiduciosamente l’aiuto, nella consapevolezza dell’incapacità dell’uomo a qualunque gesto salutare se non lo dispone a ciò l’aiuto soprannaturale del Signore (Concilio di Trento, Sessione VI, can. 1 Denzinger-Schönmetzer 1551), che appunto con la preghiera si implora; ma se si implora vuol dire che si ha la speranza teologica di ottenerlo, e con ciò quasi si esperimenta la bontà di Dio e ci si educa al colloquio con Lui. Sarà cura del confessore aiutare il penitente a comprendere tutto ciò, quando questi sia di modeste risorse spirituali. È quindi evidente che, accanto a una proporzione in certo senso quantitativa tra il peccato commesso e la soddisfazione da compiere, occorre tener presente il grado di pietà, la cultura spirituale, la stessa capacità di comprensione e di attenzione e, eventualmente, la tendenza allo scrupolo del penitente. Pertanto, mentre bisogna profittare della penitenza sacramentale per invogliare i penitenti alla preghiera, ci si dovrà attenere ordinariamente anche al principio che è meglio una penitenza modica, ma eseguita con fervore, piuttosto che una ingente, ma non eseguita, o eseguita con animo infastidito.
5. Quando la penitenza deve consistere non solo in preghiere, ma anche in opere, si debbono scegliere quelle in forza delle quali il penitente si eserciti con successo nella virtù e in ordine a questa acquisisca, accanto all’abito soprannaturale, infuso con la grazia, anche una connaturale propensione e in tal modo egli sia facilitato nell’operare il bene e nel fuggire il male. In materia deve ordinariamente applicarsi un certo “contrappasso”, quasi una medicina degli opposti, cosa questa tanto più necessaria, o almeno utile, quanto più il peccato è stato lesivo di beni fondamentali: per esempio, al crimine dell’aborto, oggi tragicamente tanto diffuso, potrebbe essere appropriata risposta penitenziale l’impegno nella difesa della vita e nell’aiuto ad essa, secondo tutte le forme che la carità sa escogitare in rapporto ai bisogni sia dei singoli che della società: idonea risposta in relazione ai peccati contro la giustizia, che oggi tanto avvelenano i rapporti tra le persone e inquinano la società, potrebbe essere, presupposta la doverosa restituzione del maltolto, la larghezza della carità in modo da superare la misura del danno inflitto al prossimo, sull’esempio di Zaccheo, che disse a Gesù: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto” (Lc 19, 8); e non sarà difficile, quando si è giudicati dai criteri della fede, trovare analoghe risposte per gli altri peccati.
A questo punto sarà utile una riflessione su eventuali penitenze che siano fisicamente afflittive. Fermo restando che la penitenza anche corporale è doverosa in termini generali, anzi santa, ricordo che nel Catechismo della Chiesa Cattolica questo tipo di penitenze, in rapporto al sacramento della Riconciliazione, è riassunto nel termine “digiuno” (cf. CCC, n. 1434). Invero, salvo casi di malattia o di debolezza, una ragionevole limitazione del cibo è normalmente possibile, e tanto più lodevole, quando il corrispettivo di ciò che si sottrae alla propria soddisfazione viene erogato in carità; ma è necessaria da parte del confessore ogni cautela prima di assegnare o anche semplicemente permettere pratiche penitenziali tormentose. In questo campo offre occasione di generosa penitenza il lavoro, specialmente quello materiale, dotato come è anche di una virtù educatrice del corpo, o che il lavoro stesso si debba svolgere per dovere professionale, o che si assuma liberamente: infatti il Creatore ha prescritto per il primo uomo, e per tutti gli uomini, il lavoro come penitenza: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gen 3, 19); il lavoro, infatti, non è condanna in sé e per sé – anzi la natura umana lo esige come necessario mezzo di sviluppo e di elevazione – ma, divenuto gravoso a causa del peccato, assurge in chi lo compie soprannaturalmente al valore di espiazione.
6. Questi pensieri, che immediatamente rivolgo a voi, partecipanti all’Udienza, ma che propongo a tutti i sacerdoti del mondo, mentre nella Chiesa è già incominciata la riflessione sui temi dell’Anno Santo, enunziati nella Lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente, vogliono sottolineare mezzi e fini, impegni e speranze, perenni nella Chiesa, ma particolarmente significativi per il prossimo Giubileo.
Insieme preghiamo ora Gesù, Sacerdote Eterno, affinché ci conceda lucidità di giudizio e carità pastorale per una dedizione sempre più generosa nel servizio penitenziale a vantaggio di tutti i fratelli. Di questa implorata grazia sia pegno per tutti voi l’Apostolica Benedizione, che ben di cuore vi imparto.
© Copyright 1995 - Libreria Editrice Vaticana
Copyright © Dicastero per la Comunicazione